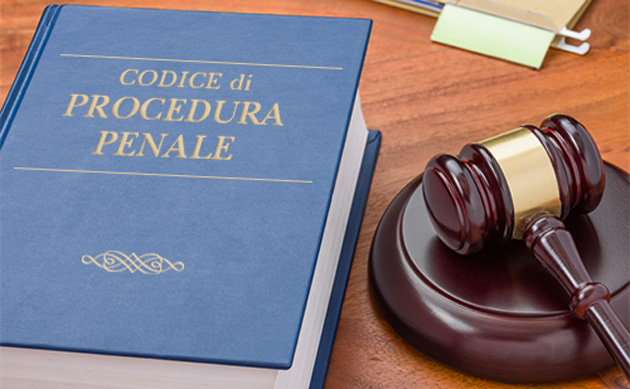CONNESSIONE EX ART. 12 C.P.P.
Nell’esaminare una vicenda nella quale occorreva valutare se il delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di reati di corruzione, tutti contestati ad un medesimo imputato, fossero connessi ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. con un delitto tributario (frode fiscale) ascritto allo stesso imputato ma commesso in concorso con altro soggetto, al quale non erano invece addebitati né il delitto associativo, né i delitti contro la P.A., la Suprema Corte ha affermato, in tema di intercettazioni telefoniche relative a procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020 (antecedente alla riforma introdotta dal D.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. dalla L. 25 giugno 2020 n. 70) che i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. “senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi” (Cass. pen., sez. IV, n. 28276 del 13 aprile 2022).
Va precisato che nella vicenda al vaglio della Suprema Corte non era in discussione che l’autorizzazione ab origine non riguardasse il delitto tributario, così come era stata pacificamente esclusa l’esistenza di una connessione sotto il profilo teleologico ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p.
La citata sentenza pare porsi in contrasto con l’orientamento, sino ad ora consolidato, secondo cui, a differenza della connessione teleologica, la connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. rileva processualmente solo se “sia riferibile ad una esecuzione monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi poiché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale” (Cass. pen., sez. VI, n. 37524 del 15 settembre 2021; Cass. pen., sez. VI, n. 37519 del 14 settembre 2021; Cass. pen., sez. I, n. 24718 del 22 maggio 2008, ma soprattutto Cass. pen., SS.UU., n. 53390 del 26 ottobre 2017; in motivazione anche Cass. pen., SS.UU., n. 23166 del 28 maggio 2020).
La sentenza afferma che la più recente giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che il principio per il quale non vi è necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi troverebbe la propria giustificazione nel fatto che il rapporto di connessione qualificata ex art. 12 c.p.p., riguarda i fatti nella loro oggettività, mentre resta estranea, ai fini dell’utilizzabilità delle intercettazioni, la posizione soggettiva degli autori del reato, posto che il decreto autorizzativo concerne il reato nella sua realtà materiale restando indifferenti i destinatari del provvedimento, tanto che le intercettazioni possono essere disposte anche se il procedimento è iscritto a carico di ignoti e non è dubbio che gli esiti possano essere utilizzati quando gli autori del reato vengano individuati.
A sostengo la citata sentenza richiama una precedente decisione di altra sezione (Cass. pen., sez. V, n. 37697 del 29 settembre 2021) che a sua volta richiama un passaggio motivazionale di altra pronunzia (per la verità entrambe dello stesso relatore) dove si afferma che la “disciplina di utilizzabilità afferisce alla diversità dei reati, non alla diversità dei soggetti tutti concorrenti nel medesimo reato. Invero, le intercettazioni non richiedono che gli indizi di reato siano individualizzanti: i presupposti dell’attività di intercettazione sono riferiti alla esistenza del reato e non alla responsabilità dei singoli concorrenti” (Cass. pen., sez. V, n. 1757 del 17 dicembre 2020).
In tal modo la sentenza intenderebbe far notare che il percorso argomentativo sulla base del quale deve giungersi all’affermazione della sussistenza della connessione di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., anche in assenza di comunanza fra tutti i correi dell’unico disegno criminoso, passa per la precisazione che la ratio della norma che porta ad escludere, nell’ipotesi in cui uno degli imputati in concorso non partecipi al disegno criminoso altrui, il discostamento dalle ordinarie regole di competenza poste a salvaguardia del principio del giudice naturale non può essere estesa alla nozione di connessione rilevante in tema di intercettazioni, ambito in cui ciò che rileva è il legame sostanziale fra i reati. Detto in altri termini, sebbene pur sempre descritta dall’art. 12 c.p.p., un conto sarebbe la connessione ai fini dello spostamento di competenza ex art. 16 c.p.p., altro invece sarebbe la connessione rilevante in tema di intercettazioni ex art. 270 c.p.p.: solo in tale ultimo caso dovrebbe intendersi come “legame sostanziale” e la visuale soggettiva sarebbe irrilevante.
Di conseguenza – si afferma – pare corretto concludere che se le intercettazioni attengono al fatto-reato nella sua oggettività, l’identità del procedimento si fonda sul “legame sostanziale” dei reati e questo legame è indipendente dalla vicenda procedimentale, discende che l’identità del disegno criminoso deve ‘tenere legati’ i fatti-reato, ma non necessariamente tutti i compartecipi.
Dunque, con tale decisione la Corte ha affermato che, nonostante il delitto fiscale non fosse riferibile ad una condotta monosoggettiva e l’identità del disegno criminoso non fosse stato affatto comune a tutti i compartecipi, è possibile ritenere l’utilizzabilità delle intercettazioni senza violare il disposto dell’art. 270 c.p.p. e il principio enunciato dalle Sezioni unite Cavallo (secondo cui “in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.” Cass. pen., SS.UU. n. 51/2019), ritenendo a tal fine irrilevante il presupposto dell’identità soggettiva per affermare la stretta connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. e così di fatto parificando tale tipo di connessione alla connessione prevista dalla lettera c) del medesimo articolo.
Ci si domanda se sia possibile relativizzare il contenuto di quella che sembra essere una norma descrittiva e ricognitiva di una fenomenologia della realtà: legame sostanziale non significa necessariamente oggettivo ma semmai che attiene alla essenza di una cosa. La ‘visuale soggettiva’ pareva essere perciò il tratto caratteristico determinante di quel fenomeno descritto dalla connessione di cui alla lett. b) c.p.p., ossia ciò che le conferiva l’essenza e, dunque, ciò che pure la distingueva da quella oggettiva-finalistica descritta alla lettera c).